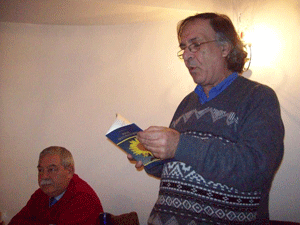Insieme nel percorso. Grazie!
Sandra Carresi (Firenze)
Che serata stupenda ho trascorso con gli amici poeti a Vigevano, grazie Ciccio,
sono tornata a Novara in pomeriggio (x lo sciopero dei treni) stanca ma contenta.
Anna Scarpetta (Novara)
Grazie per la bella serata di ieri ; siamo stati veramente bene e mi dispiace poi di esserci persi alla fine per i saluti.
Fai ancora i complimenti a tua moglie per il bellissimo intrattenimento musicale…
Carmela Di Rosa (Alessandria)
Grazie, Ciccio! E' stata una serata piacevolissima e fortemente educativa.
Anna Maria Folchini (Milano)
Davvero..da ripetere. ..dovunque!"
Paola Surano (Sesto Calende (Va)
Ieri sera a Vigevano serata di poesia, canti e racconti.
Liliana Calabrese - bella e dolcissima - ha cantato in molte lingue... italiano, francese, sardo e siciliano.
Non potho reposare dei Tazenda, tra le altre.
Abbiamo recitato versi di amici e di grandi poeti.
Abbiamo mangiato e bevuto, abbiamo condiviso sorrisi e risate, emozioni e pensieri.
Abbiamo ascoltato le voci di camminatori e di viaggiatori. Abbiamo ripercorso strade antiche.
Abbiamo parlato delle nostre speranze.
Siamo stati bene, molto bene.
Grazie Ciccio.
Carla De Bernardi (Milano)
A VIGEVANO PER I MERCOLEDÍ
LETTERARI
DI AVOLA IN LABORATORIO
…la
felicità è una piccola cosa, è un bocciolo di rosa su cui si posa l’ape per succhiare il
nettare e poi andar via
 “La nebbia agli irti colli”…già Carducci! E chi non
conosce i versi di “San Martino”! E poi questa nebbia che lenta cala in
goccioline appesantite dal freddo, chissà perché mi fa pensare al Goldoni, alle
dame con la bauta a coprire il volto, le gondole che
scivolano lievi tra i canali, ai misteri che si intrecciano tra le calli, ai sospiri della laguna. “La nebbia agli irti colli”…già Carducci! E chi non
conosce i versi di “San Martino”! E poi questa nebbia che lenta cala in
goccioline appesantite dal freddo, chissà perché mi fa pensare al Goldoni, alle
dame con la bauta a coprire il volto, le gondole che
scivolano lievi tra i canali, ai misteri che si intrecciano tra le calli, ai sospiri della laguna.
Quando c’è luce, con gli occhi
riusciamo a seguire le figure che si allontano verso l’orizzonte, ma nella
nebbia i rumori si spengono, le luci si sfumano, le impronte si perdono mentre
le sagome sembrano dileguarsi in un oltre metafisico, quasi irreale.
Però… aspetta un momento… oggi il calendario non ricorda
quel soldato di Tours che divise a metà il proprio
mantello né ci troviamo tra quelle colline dalle fronde spogliate dall’autunno.
Siamo, invece, a ridosso di certe “aride sponde” e abbiamo “volti i guardi” alle acque del “varcato” Ticino e questa Piazza
Ducale, come tutte le altre, agorà politico e centro di aggregazione sociale
della vita cittadina, con questi loggiati che le fanno ala e la rendono snella
mentre l’edificio sacro dalla linee insolite e l’andamento sinuoso, la fa
apparire statica e ben salda nella maestà della fede, mi ricorda altri luoghi
del cuore.
 Gli aghi della temperatura che scende mi punzecchiano il
viso e le mani, ma non mi importa…sto aspettando il mio gruppo di amici e
questo mi rasserena e mi regala felicità. Alla spicciolata arrivano tutti così ho
l’opportunità di conoscere di presenza persone che come me amano scrivere e persone esperte dei vari Cammini
europei. Gli aghi della temperatura che scende mi punzecchiano il
viso e le mani, ma non mi importa…sto aspettando il mio gruppo di amici e
questo mi rasserena e mi regala felicità. Alla spicciolata arrivano tutti così ho
l’opportunità di conoscere di presenza persone che come me amano scrivere e persone esperte dei vari Cammini
europei.
Salutare Francesco e Liliana insieme
alla loro figlia è rassicurante, ma mi sembra quasi strano trovarli qui, visto
che nel mio immaginario sono abituata a seguirli in una realtà geografica ben diversa da questa. Da abili
tessitori di trame di fraternità, socializzano cultura e amicizia partecipata e
ben sanno che “la poesia ovunque ha la sua valenza/si esprime negli occhi della
luce, nelle righe del silenzio” perché “l’essenza della bella poesia serpeggia
come lieto/delicato vento” (Anna Scarpetta, “Il mondo della musa”). Sono proprio
due anime in un nocciolo loro due, anime affini e diverse nell’intima essenza,
ma complementari ed omologati ad un medesimo sentire giusto come quella
“mandorla siamese” della foto di Fabio Montalto nella silloge poetica di
Cettina Lascia Cirinnà.
Filosofi puri di vita come pure
dell’arte della paziente maieutica mettono in atto certe upanisad,
riuscendo anche a trasmettere
un tipo di insegnamento mistico.
Immersa in questo bellissimo convivio, mi
sento tra l’Olimpo e il mare, su quel monte Pimpleo dove risiedono le muse e pur nella mia  esuberanza di carattere, nella sempre
meno conclamata allegria, non incline alla reticenza e alla misantropia ma più all’apertura
verso l’esterno mi piace dare spazio agli altri, fare largo a chi ha qualcosa
da dire, ascoltare chi ha qualcosa da proporre e da insegnare, accogliere senza
riserva gli intenti e i desideri degli altri, pronta a percepire i battiti di
chi come ama le lettere ed il potere multiforme della poesia. Ecco perché mi
sento di dire che anch’io “ho visto il passaggio delle stagioni,/ho respirato le loro fragranze,/ho sentito lo schiaffo del
vento /e il bacio del sole./…ho avuto paura e ho gioito”
(Sandra Carresi, “Alle mie ragazze”). esuberanza di carattere, nella sempre
meno conclamata allegria, non incline alla reticenza e alla misantropia ma più all’apertura
verso l’esterno mi piace dare spazio agli altri, fare largo a chi ha qualcosa
da dire, ascoltare chi ha qualcosa da proporre e da insegnare, accogliere senza
riserva gli intenti e i desideri degli altri, pronta a percepire i battiti di
chi come ama le lettere ed il potere multiforme della poesia. Ecco perché mi
sento di dire che anch’io “ho visto il passaggio delle stagioni,/ho respirato le loro fragranze,/ho sentito lo schiaffo del
vento /e il bacio del sole./…ho avuto paura e ho gioito”
(Sandra Carresi, “Alle mie ragazze”).
E mentre ascolto le bellissime rime
declamate in dialetto siciliano da Carmela Di Rosa e quelle proposte dalle
altre amiche (Paola Surano, Sandra Carresi, Anna
Maria Folchini
Stabile),
il discorrere di chi riesce a cogliere gli attimi dell’esistenza, i racconti di
quanto riportano il proprio vissuto da pellegrini (Cristina Menghini,
Alessandro Ghisellini,
Luciano  Callegari,
Lalla Fumagalli, Giuliano Mari, Ruggero Giuseppetti, Stefanino Valmadre, Riccardo Latini, Carla De Bernardi), lo
stesso parlare dell’Editore Urso che mi fa pensare ai colori fulgenti della sua
terra, mi salgono alle labbra i versi in cui
la Dicknson
dice che la felicità è una piccola cosa, è un bocciolo di rosa su cui si posa l’ape
per succhiare il nettare e poi andar via. Così mi vien fatto di
paragonare questo momento di coralità sia a quel “girasole impazzito di sole”
immortalato da Montale sia a quello riportato sulla copertina della raccolta
poetica “Poesie di un pellegrino”, lette dallo stesso autore (Davide Bove) e mi
dico che stasera noi siamo i petali di quel fiore splendente ed anche api che
aspirano nettare prezioso che si sprigiona da questa relazione umana e ci fa
sentire parte di un magma che fluisce dai pensieri; e siamo anche chicchi di
una “risata gialla e dura”, serbata intatta in quella pannocchia celebrata da
Federico Garcia Lorca. Callegari,
Lalla Fumagalli, Giuliano Mari, Ruggero Giuseppetti, Stefanino Valmadre, Riccardo Latini, Carla De Bernardi), lo
stesso parlare dell’Editore Urso che mi fa pensare ai colori fulgenti della sua
terra, mi salgono alle labbra i versi in cui
la Dicknson
dice che la felicità è una piccola cosa, è un bocciolo di rosa su cui si posa l’ape
per succhiare il nettare e poi andar via. Così mi vien fatto di
paragonare questo momento di coralità sia a quel “girasole impazzito di sole”
immortalato da Montale sia a quello riportato sulla copertina della raccolta
poetica “Poesie di un pellegrino”, lette dallo stesso autore (Davide Bove) e mi
dico che stasera noi siamo i petali di quel fiore splendente ed anche api che
aspirano nettare prezioso che si sprigiona da questa relazione umana e ci fa
sentire parte di un magma che fluisce dai pensieri; e siamo anche chicchi di
una “risata gialla e dura”, serbata intatta in quella pannocchia celebrata da
Federico Garcia Lorca.
 In situazioni come questa il
sentire si condensa in sensazioni forti ed impresa ardua diviene il voler
ingabbiare i pensieri e ordinarli in categorie già stabilite mentre le idee si
accavallano nella mente e gli affetti galoppano nelle emozioni. In situazioni come questa il
sentire si condensa in sensazioni forti ed impresa ardua diviene il voler
ingabbiare i pensieri e ordinarli in categorie già stabilite mentre le idee si
accavallano nella mente e gli affetti galoppano nelle emozioni.
E Liliana, donna dalle mille
risorse e all’apparenza fragile come giunco ma in verità robusta come quercia,
mette cuore nell’espressività del canto mentre le dita pizzicano le corde e fermano le note
sulla tastiera della chitarra; ogni sfumatura della sua voce cattura perché sa
ben interpretare sillabe e parole, incanti e musica.
“L’inferno dei viventi non è
qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che
abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme” (Italo Calvino ne “Le città invisibili”). A noi, però, non interessa certo
scegliere la via più facile, accettando l’inferno fino a diventarne parte
integrante e non vederlo più solo perché nella società attuale “si è passati a
un atteggiamento distaccato verso un mondo oggettivo, esterno che però non ha
più in sé nessun fondamento etico” (G. Germani, “Tiziano Terzani:
la rivoluzione dentro di noi”). A noi interessa scegliere la via più rischiosa,
attuando “attenzione e apprendimento continui” dato che “cercare e saper
riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare , e dargli spazio”(Italo Calvino, o.c.).
 Occorre per questo tenere
presenti i fini primari della vita umana quali interesse, amore, doveri etici e religiosi, liberazione intesa quale libertà,
riposo, felicità e rinascita che significano trascendere gli stessi scopi della vita. Ecco perché i nostri passi muovono verso Itaca e “…questo viaggio
ci porta ad indagare quella cosa, in fondo misteriosa, che è la nostra mente,
al cui interno sussistono tanto la pace, la calma aurorale e beata, quanto
l’avvicendarsi conflittuale e bellicoso dei rapporti con il mondo” (G. Germani, o.c.). Pertanto ciò che ci aspettiamo dal nostro
viaggio, sia esso reale, onirico, surreale, fantastico è la capacità di non
perdere mai la speranza e mantenere la tenerezza, inventare mete e raggiungere
obiettivi, riuscire a tenere nel palmo della mano un granello di sole e temere
il buio, voler accettare e capire il silenzio e non aver paura del rumore della
folla, gridare al vento parole senza senso e commuoversi per un cielo stellato
o “un passerotto morente”. E solo quando saremo in grado di acciuffare ciò che
da sempre andiamo cercando, potremo dire di non aver “vissuto invano” anche
perché “La meta della vita é un viaggio di cui (noi stessi non sappiamo) un
granché, tranne la sua direzione (che) è dal fuori verso il dentro e dal
piccolo sempre più verso il grande” (Tiziano Terzani). Occorre per questo tenere
presenti i fini primari della vita umana quali interesse, amore, doveri etici e religiosi, liberazione intesa quale libertà,
riposo, felicità e rinascita che significano trascendere gli stessi scopi della vita. Ecco perché i nostri passi muovono verso Itaca e “…questo viaggio
ci porta ad indagare quella cosa, in fondo misteriosa, che è la nostra mente,
al cui interno sussistono tanto la pace, la calma aurorale e beata, quanto
l’avvicendarsi conflittuale e bellicoso dei rapporti con il mondo” (G. Germani, o.c.). Pertanto ciò che ci aspettiamo dal nostro
viaggio, sia esso reale, onirico, surreale, fantastico è la capacità di non
perdere mai la speranza e mantenere la tenerezza, inventare mete e raggiungere
obiettivi, riuscire a tenere nel palmo della mano un granello di sole e temere
il buio, voler accettare e capire il silenzio e non aver paura del rumore della
folla, gridare al vento parole senza senso e commuoversi per un cielo stellato
o “un passerotto morente”. E solo quando saremo in grado di acciuffare ciò che
da sempre andiamo cercando, potremo dire di non aver “vissuto invano” anche
perché “La meta della vita é un viaggio di cui (noi stessi non sappiamo) un
granché, tranne la sua direzione (che) è dal fuori verso il dentro e dal
piccolo sempre più verso il grande” (Tiziano Terzani).
 Itaca è incertezza e certezza, miraggio e realtà,
sogno e risveglio, cammino e stasi e tutti i Lestrigoni e i Ciclopi tanto temuti non sono altro che gli ostacoli da noi stessi creati,
pensando che non possiamo perché come afferma Jorge Bucay “…andiamo in giro incatenati a centinaia di paletti
che ci tolgono la libertà” e “l’unico modo per sapere se possiamo farcela è
provare, mettendoci tutto il cuore… tutto il nostro cuore”. E questo concetto è
anche l’essenza di quanto di volta in volta sono andati enunciando i pellegrini che hanno
partecipato la loro esperienza di uomini liberi nello spirito e nei pensieri,
uomini desiderosi di raggiungere quella meta che si è profilata in lontananza,
quel richiamo che ha invaghito le loro menti, consapevoli che in fondo sempre “C’è un sentimento/quando
guardo a occidente/e la mia anima/brama/ di partire” (Led Zeppelin). Itaca è incertezza e certezza, miraggio e realtà,
sogno e risveglio, cammino e stasi e tutti i Lestrigoni e i Ciclopi tanto temuti non sono altro che gli ostacoli da noi stessi creati,
pensando che non possiamo perché come afferma Jorge Bucay “…andiamo in giro incatenati a centinaia di paletti
che ci tolgono la libertà” e “l’unico modo per sapere se possiamo farcela è
provare, mettendoci tutto il cuore… tutto il nostro cuore”. E questo concetto è
anche l’essenza di quanto di volta in volta sono andati enunciando i pellegrini che hanno
partecipato la loro esperienza di uomini liberi nello spirito e nei pensieri,
uomini desiderosi di raggiungere quella meta che si è profilata in lontananza,
quel richiamo che ha invaghito le loro menti, consapevoli che in fondo sempre “C’è un sentimento/quando
guardo a occidente/e la mia anima/brama/ di partire” (Led Zeppelin).
Ma Itaca è anche ritorno, è
riposo, è casa, è sicurezza, è serenità, è famiglia ed il talamo segreto,
costruito e modellato sui rami del vecchio olivo, sarà sempre simbolo dell’uomo
che dopo aver
esaudito il proprio bisogno di conoscenza e aver sfidato “i mostri sulla via” e “Positone
asprigno” torna all’isola che gli “ha dato il bel viaggio” (“Itaca”, K. Kavafis).
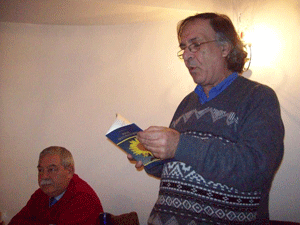 Itaca… simbolo e dannazione di
quel viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda e che fa percepire quel senso
d’appartenenza di cui l’essere umano ha così tanto bisogno è assai gratificante
come recondita armonia. “Tutto ha un significato psichico,
una casa, un luogo, un avvenimento, al di quello apparente. Infatti ad ogni immagine esteriore corrisponde un’immagine
interiore che evoca in ciascuno di noi una realtà molto più vera e profonda e
in questo passaggio il senso dei simboli ci aiuta ad andare oltre il visibile;
il “vedere dentro” trascende il linguaggio attraverso certi veicoli di
significato quali le metafore, le allegorie, le similitudini”. “Multas per gentes e multas per aequora vectus”
(V. Catullo) mi dico quando appoggio di nuovo i passi sul marciapiede della
stazione di S. M. Novella e penso che non “Vi è felicità più grande…/la mente
libera… e a casa /si torna per poi riposare nel letto sospirato” (V. Catullo,
“A Sirmione”). Itaca… simbolo e dannazione di
quel viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda e che fa percepire quel senso
d’appartenenza di cui l’essere umano ha così tanto bisogno è assai gratificante
come recondita armonia. “Tutto ha un significato psichico,
una casa, un luogo, un avvenimento, al di quello apparente. Infatti ad ogni immagine esteriore corrisponde un’immagine
interiore che evoca in ciascuno di noi una realtà molto più vera e profonda e
in questo passaggio il senso dei simboli ci aiuta ad andare oltre il visibile;
il “vedere dentro” trascende il linguaggio attraverso certi veicoli di
significato quali le metafore, le allegorie, le similitudini”. “Multas per gentes e multas per aequora vectus”
(V. Catullo) mi dico quando appoggio di nuovo i passi sul marciapiede della
stazione di S. M. Novella e penso che non “Vi è felicità più grande…/la mente
libera… e a casa /si torna per poi riposare nel letto sospirato” (V. Catullo,
“A Sirmione”).
E Itaca è anche questo: partire
per poi
ritornare, cogliendo l’attimo fuggente e affidandosi al domani quanto meno
possiamo anche perché si prova una gioia infinita quando riusciamo a realizzare
ciò che in cuore era desiderato (dai poeti Orazio e Catullo).
Itaca è una speranza viva, una
chimera, un sogno da destare, un faro verso cui dirigere la rotta; Itaca è una
“valle dell’ozio”… uno spiazzo più o meno ampio, uno spazio mentale più o meno
piccolo che ognuno di noi può trovare nel suo atlante
psichico personale” (Salvatore Di Pietro, “Nella valle dell’ozio”). Talvolta
nella vita ci troviamo come in quel tratto del Cammino che va da Saint Jean Pied-de-Port a Roncisvalle… il più
impervio, il più difficile a superare, banco di prova delle forze fisiche e di
quelle interiori di ciascun pellegrino e si ha timore di non farcela perché la
forza d’animo viene meno, ma “poi sopraggiunge una forza, una forza strana che
non puoi misurare o controllare, una forza sconosciuta, oscura, mai sentita che
ti trascina di nuovo dentro (alla vita) e non sai come e perché” (Letterio Pomara, “
La Fuerza
del Camino”).
Così “Come le api raccolgono il
nettare/da piante diverse e miele ne fanno/ unendo l’essenza,/
e più non è possibile distinguere/il nettare di questa dal nettare di
quella,/così le creature si fondono nell’Essere./… non importa ciò che sono
sulla terra./Tornano all’essere/all’essenza
più fine/al sé di tutto il mondo” (dalle “Upanisad”).
Lucia Bonanni
|
 FORUM
FORUM